Diceva il Machiavelli che il principe «o spende del suo o di quello d’altri». Se spende del suo ha da essere parsimonioso, se di quello d’altri «non dee lasciare indrieto forma alcuna di liberalità». Così si ritorna a parlare di distribuire in busta paga gli accantonamenti per il TFR, come sostegno per i consumi dei lavoratori (tanto sono già soldi loro). Bisogna dire che i doni che Firenze faceva alla patria in altri tempi erano di migliore qualità.
Quella sul TFR non è una guerra di religione, e l’idea di distribuirlo subito, senza attendere la fine del rapporto di lavoro, risale ad almeno quarant’anni fa. Per apprezzarla come si deve vale la pena di rifarsi alle origini. Il TFR nasce cent’anni fa come indennizzo nel caso di licenziamento immotivato (ma guarda chi si vede!) e non è un caso che i primi a rivendicarlo siano stati i giornalisti, una categoria che, per via dei suoi rapporti con la politica, si trovava particolarmente esposta a rischi del genere. Venne poi gradualmente esteso ad altre categorie di lavoratori e credo abbia trovato una sistemazione generale con la legge sull’impiego privato del 1924. Per altri trenta o quarant’anni conservò la fisionomia iniziale; poi i contratti di categoria incominciarono ad inserire clausole di riconoscimento (all’inizio parziali) quale che fosse il motivo dell’interruzione del rapporto di lavoro. È evidente che a tal punto era diventato in sostanza una forma di salario differito, che non spiaceva ai lavoratori (c’era chi con il TFR – che allora si chiamava liquidazione – si comprava la casa) e, tutto sommato, nemmeno alle aziende. L’obiezione che a volte si faceva da parte delle aziende era che l’importo veniva calcolato sull’ultimo stipendio, e quindi incorporava gli aumenti che il lavoratore aveva avuto nel corso della sua vita di dipendente: non solo quelli derivanti dai progressi di carriera ma anche quelli (e lì la polemica era particolarmente aspra) dai famigerati scatti di anzianità, che molti imprenditori consideravano più o meno come un furto.
Critiche di questo genere portarono ad una riforma importante, ossia alla costituzione del TFR come accantonamento degli importi calcolati sulle retribuzioni percepite anno per anno (quindi non soggetti ad aumenti) e solo difesi contro l’inflazione. Vale la pena di considerare che la formula adottata per l’indicizzazione (1,5 per cento fisso più i ¾ del tasso di inflazione che si fosse effettivamente verificato) postulava una rivalutazione “neutra” solo nel caso che il tasso d’inflazione fosse il 6 per cento. Se l’inflazione fosse stata più bassa, ci avrebbe guadagnato il lavoratore; se fosse stata più alta, l’azienda. Poiché erano gli anni dell’inflazione a due cifre, ci si può chiedere se erano neutrali anche coloro che tale formula avevano escogitato. Ma lasciamo stare. De minimis non curat praetor.
Quello che importa rilevare è che in questo modo la vecchia liquidazione si è trasformata in un vero e proprio risparmio forzoso, sul quale viene anche pagato quello che in sostanza è un interesse. Il carattere di forzatura era del resto implicitamente riconosciuto anche dal legislatore, che infatti ha previsto per il lavoratore la possibilità di attingere in anticipo su quanto accantonato, mettendosi d’accordo con il datore di lavoro o addirittura esigendolo (sia pure solo in parte) in determinati casi di necessità riconosciuta – come in effetti molti hanno fatto. Di conseguenza la proposta attuale, soprattutto se l’eventuale prelievo dovesse avvenire solo per libera scelta, non cambierebbe poi di molto la situazione attuale, almeno per quanto riguarda il lavoratore. Disturba un po’ l’enfasi con la quale viene presentata, come se fosse chissà quale piacere che il principe fa al suddito, mentre è solo un tentativo di fargli spendere soldi che comunque sono già suoi.
Per le aziende dovrebbe essere una riforma senza spesa, perché in definitiva non sono soldi loro. O meglio non lo sarebbero se fossero effettivamente accantonati. Però si sa che per molte aziende si tratta invece di un piccolo peculio che va ad incrementare il capitale d’esercizio ad un costo presumibilmente inferiore a quello di un prestito bancario, ammesso che gli riesca di ottenerlo in un momento nel quale le banche non sembrano particolarmente inclini a finanziare il sistema produttivo. Anche se ora si parla di un possibile intervento della Cassa Depositi e Prestiti, problemi del genere bastano a spiegare la reazione non positiva della Confindustria, e anch’essa non ha tutti i torti, perché anch’essa potrebbe rinfacciare al governo di fare il grande con i soldi degli altri.
Inoltre (anche se a pensare male si fa peccato) può mettere una pulce nell’orecchio la coincidenza tra questa proposta e l’assalto all’art. 18. Lo si voglia o no, la prospettiva di dover pagare una liquidazione consistente è comunque un disincentivo ai licenziamenti facili. Questo fatto non avrà particolare incidenza sul lavoro dei giovani, sia perché i loro TFR hanno comunque importi limitati sia – e anche soprattutto – perché – comunque vada a finire la questione dell’art. 18 – è chiaro e più che prevedibile che loro ne resteranno fuori. Per i lavoratori con una certa anzianità, invece, se un’eventuale riformulazione della disciplina attuale prevedesse la sostituzione del reintegro con la corresponsione di un compenso in denaro, il fatto di risparmiare sul TFR (già falcidiato in costanza di rapporto) potrebbe aiutare a contenere l’entità dell’esborso. Non subito, certo. Ma in prospettiva? Fra qualche anno? (a.g.)

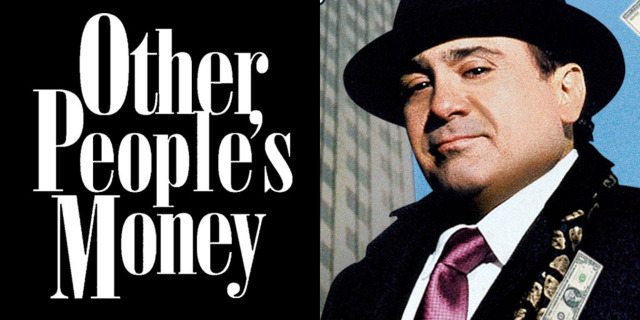
Be the first to comment on "Poiché spendo i miei denari…(Don Giovanni)"